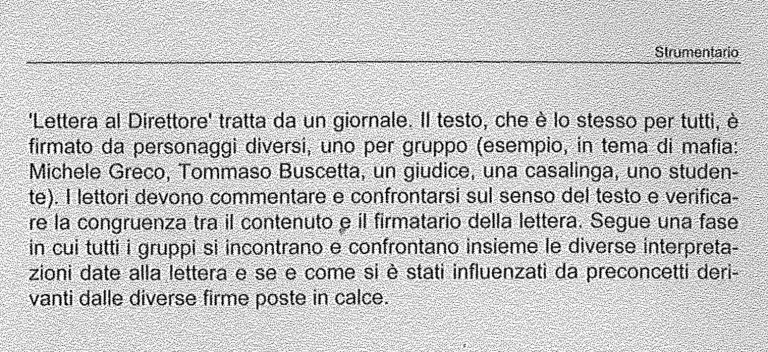Premessa.
Lettera al direttore è un gioco sui pregiudizi. Così viene presentato implicitamente, nella spiegazione di come si svolge. In particolare, viene rimarcato il possibile contrasto tra il contenuto di una lettera e il proprio autore.
Ovviamente potrebbero esserci diverse ragioni perché ciò accada. Come quella di una sorta di intento manipolatorio proprio di chi usa lo strumento della lettera per fare una ricostruzione dei fatti e della realtà a sé favorevole. Una sorta di captatio benevolentiae in danno del lettore/destinatario.
Perché ciò riesca, però, occorre che chi scrive abbia una sufficiente capacità in tal senso. Così la scrittura verrebbe a costituire lo strumento con cui si esercita la retorica se non la sofistica.
Ma una simile competenza quanto può dirci della personalità di chi scrive? e una persona con tali competenze, in linea generale, può rendersi protagonista di determinati fatti piuttosto che di altri?
Il senso della domanda si rifà all’idea che determinate competenze, quali appunto l’uso appropriato della scrittura, si associno ad un certo livello di abilità nel rapportarsi alla realtà. Cosicchè, in caso di difficoltà a raggiungere determinati obiettivi, si propenda per l’uso di strumenti più sofisticati della violenza: come appunto la parola e la capacità di ristrutturazione del campo di azione. L’abbiamo già visto quando abbiamo parlato dell’esercizio dei novi punti e dei cambiamenti di Tipo1 e di Tipo2.
Una simile convinzione, come abbiamo detto in più occasioni, l’abbiamo tratta dalla lettura dei testi di Henry Laborit.
Ma possiamo giungere a questa conclusione per altra via.
In essa gioca un ruolo fondamentale la valenza della scrittura come esercizio costante di rielaborazione della realtà e dunque anche come difesa dell’io. In una certa misura in alternativa a quelle difese automatiche di cui abbiamo parlato in passato. Una sorta di medicina.
Per una scrittura efficace e convincente bisogna essere se stessi e l’altro. L’altro che legge e che interpreta. Una sorta di schizzofrenia sana. Ciò in quanto quando si scrive si produce lo sforzo di un collegamento tra i diversi contenuti esposti, utile certo per chi scrive per, così dire, non perdere il filo, ma pure per colui cui è destinato, quando dovesse capitargli di leggerli.
In ogni caso, lo scrittore, anche se scrivesse solo per sé, interpreterebbe comunque un doppio che comprende se stesso e un destinatario teorico della narrazione.
E ciò costituisce già un primo tipo di empatia. Si deve infatti immaginare che leggerà quel brano dovrà trovarlo comprensibile, accettabile e persino persuasivo.
Ebbene, chi compie questo sforzo empatico, con ogni probabilità difficilmente potrà compiere atti che denotino appunto assenza di empatia, come succede per i reati più gravi.
L’empatia, dagli studi delle neuroscienze, si acquisirebbe in particolare nei primi anni di vita, per cui per chi ha avuto una deprivazione da questo punto di vista, la scrittura potrebbe in qualche modo rendere il bilancio meno pesante.
E in ogni caso a seguito di danni causati ad una vittima, scriverle può rappresentare un utile esercizio di contatto che potrebbe portare l’autore ad un esercizio di empatia postuma, fondamentale per la comprensione della gravità di quanto compiuto.
Non è un caso che il percorso di conciliazione tra parti divise da fatti di sangue venga fatto esordire con una fase in cui la scrittura funge da strumento di apertura del dialogo.
Per esercitarsi in tale competenza, può rivelarsi fondamentale ispirarsi a personaggi storici o fantastici dando loro voce come fa, secondo un’ idea, geniale, Paolo Puppa in Lettere impossibili Fantasmi in scena da Ibsen a Pasolini, Roma, 2009. Idea peraltro dalle potenzialità immense anche quando usata per studiare la storia: mettersi nei panni dei suoi protagonisti riecheggia non a caso sia il nostro gioco di ruolo che i giochi di ruolo basati sulla riproduzione certosina degli ambienti in cui si svolsero gli avvenimenti storici oggetto di analisi.
Più in generale, poiché scrivere comporta pure la condivisione di un codice comunicativo col destinatario, si può dire che comporti anche la condivisione di valori comuni. Così come tra nemici l’appartenenza al genere umano, riecheggiando le parole di Gandhi quando ammoniva di non trascurare mai che il nostro nemico, anche il più acerrimo, è pur sempre un appartenente alla nostra specie.
Ad uno spiraglio di questa possibilità sembra alludere la spiegazione di Lettera al direttore, laddove si fa l’esempio di una lettera che soltanto dopo che venga letta dai partecipanti si svela chi sia l’autore, con la possibilità che questo sia il capo di un’organizzazione criminale.
Il che appare più facile da ammettersi allorchè tale organizzazione abbia una connotazione politica, molto meno quando essa sia la mafia.
Di tale realtà però più che della scrittura dei suoi protagonisti abbiamo la descrizione di chi li persegue, come nel caso del testo Cose di Cosa nostra, Giovanni Falcone, Marcelle Padovani, Milano, 2017.
Opera che però ci priva di disporre di una descrizione dall’interno (non interna, quella si la ebbe a fornire Tommaso Buscetta a Giovanni Falcone) del pensiero del capo mafia. Sarebbe interessante conoscere il quadro ideologico di cui fanno parte gli aspetti inquietanti che portano a privare interi territori delle più elementari libertà.
Solo cercando di indagare gli aspetti valoriali che rendono possibile trovare normale, e quindi oggetto di rimozione, gli effetti dei più sanguinosi reati, sarebbe possibile contrapporli con quelli che in modo sano fanno ottenere il soddisfacimento di tutti bisogni della scala di Maslow, sino all’onore e alla reputazione, ma senza il parallelo e costante rischio di subire la sorte delle vittime. In altre parole senza rinunciare alla sicurezza e alla libertà.
Ecco perché sarebbe opportuno oltreché potenziare con mezzi ed uomini, come si suol dire, le campagne repressive, sviluppare maggiormente tutte quelle iniziative che portino a mettere a nudo e a far confrontare le culture. Comprendendo in questo sforzo la ricerca delle cause per cui certe culture che giustificano la violenza e la sopraffazione hanno la possibilità di svilupparsi. Senza escludere che certe scelte astrattamente ritenute idonee ad un contrasto efficace possano invece produrre alla lunga effetti di rinforzo.
Ma le due strategie, quella repressiva e quella del dialogo (per non chiamarla culturale giacchè anche la prima è portatrice di cultura sebbene di segno diverso) devono a loro volta essere coordinate?
E se invece fosse meglio che agissero a canale cieco?
——CONTINUA——–
Pier Gavino Sechi.