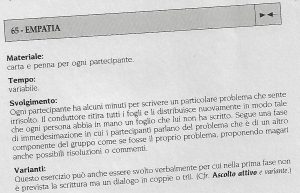Premessa.
Con un contributo illuminante che Chiara Pavone, Homo Empaticus – Jeremy Rifkin, la civiltà dell’empatia, ha scritto sul libro di questo autore, La civiltà dell’empatia, Milano, Mondadori, 2010, apriamo questo nuovo anno 2021 dedicandolo per intero all’empatia. Questo infatti dev’essere l’anno dell’empatia. Ma, come spiegheremo subito, senza più alibi.
E’ certamente un proposito provocatorio poiché, come vedremo, si pone a metà strada tra l’ottimismo e il dovere di essere ottimisti. Con la conseguente sfida al paradosso del sii spontaneo smascherato dalla scuola di Palo Alto.
Il tema di oggi è ancora una volta l’empatia con la riproposizione beneaugurale del gioco della settimana scorsa (vedi sotto). Ma dentro un quadro più ampio. Il cui oggetto di fondo è il seguente: la scienza da qualche tempo a questa parte starebbe portando alla luce prove che riscrivono la natura della nostra specie. Non più vista come sterminatrice pervicace del pianeta, ma come dotata di “naturale empatia”.
La cosa non è di poco conto. In quanto significa avere a disposizione elementi maggiori rispetto al passato in favore di quell’ ottimismo antropologico che Remo Bodei, come abbiamo detto in altri brani, contrapponeva al pessimismo antropologico.
In sostanza la specie umana sarebbe dotata di un corredo empatico di partenza che probabilmente è stato storicamente sacrificato sull’altare della sopravvivenza e della necessità di soddisfare i bisogni primari.
La vera sorpresa che però emerge da questa nuova raffigurazione della nostra specie- cioè il passaggio dall’homo oeconomicus o forse meglio predator- all’homo empaticus, starebbe, a nostro avviso, in questo. Il diverso ruolo giocato dalla cultura in tale rappresentazione. Ciò appare, infatti, tanto più clamoroso tanto più se si pensa che sinora abbiamo ritenuto la biologia la responsabile del persistere dell’immagine della nostra specie come predatrice e devastatrice della sua stessa casa. Mentre alla cultura abbiamo sinora attribuito il ruolo di processo di affrancamento da tale condizione e di traghettatrice verso la prospettiva di una riconciliazione tra uomo e creato.
Il nuovo ruolo della biologia.
In realtà questa rigida separazione di ruoli è da mettere in dubbio. A causa della perdita di innocenza proprio della cultura.
Entrano in crisi, così, migliaia di anni di storia del pensiero. Da quando cioè Platone nel Fedro, col mito della biga alata attribuiva alla ragione il compito di condurre l’anima verso il regno delle idee assecondando gli sforzi in tal senso del cavallo bianco in lotta contro il cavallo nero che spinge verso la terra.
Già da questa alleanza tra ragione e cavallo bianco del mito sembra derivare l’idea del carattere “buono” della ragione e della cultura.
Oggi che con maggiore chiarezza possiamo dire che cultura non è solo che cosa si apprende ma anche e soprattutto come si apprende, possiamo meglio cogliere che la ragione non è mai stata neutrale. Ma è stata da sempre apoditticamente ritenuta positiva.
Oggi dobbiamo, invece, cominciare a chiederle conto delle sue responsabilità.
Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa cambia in fondo ai fini dell’uscita della mille volte denunciata crisi epocale in cui versa la nostra specie.
A mio avviso cambia tutto.
Difatti una cosa è ritenere come unica soluzione possibile, come si cerca di fare tuttora incessantemente, mobilitare cultura ed educazione nel compito immane e disperato di correggere, o quantomeno mitigare, le tendenze biologiche “perverse” dell’uomo predicate dal pessimismo antropologico. Altra cosa è, smascherata la falsa innocenza della cultura e registrati i risultati che fanno luce sulla natura empatica dell’uomo, lavorare per modificare la cultura.
La biologia sembra la nostra nuova alleata, la cultura la nostra avversaria.
E, se ci pensiamo bene, in questo modo la lotta sembra meno disperata data la maggiore malleabilità della seconda rispetto alla prima.
Le principali tappe di affermazione dell’Homo empaticus.
Chiara Pavone ci offre un excursus storico culturale, che noi qui sotto sintetizziamo, delle principali tappe di un percorso che ci stanno portando a dover rileggere la nostra natura in chiave meno distruttiva di quanto veicolato dal pensiero dominante. Ne scaturisce il dovere culturale di correggere questa visione. Non è, dunque, la biologia da correggere, diremmo meno male, ma la nostra fidata alleata di sempre: la cultura.
Ad ogni scolaretto è stato detto che…
Se dell’essere umano abbiamo metabolizzato una certa idea non sarà perché ci hanno insegnato che per Thomas Hobbes (1588-1679) l’uomo è aggressivo ed egoista per natura? E che John Locke (1632-1704) non era molto da meno nel ritenere che allo stato di natura gli esseri umani sono socievoli e ben disposti gli uni verso gli altri, ma per predisposizione ce la mettono tutta pur di appropriarsi della materia del mondo facendone una proprietà produttiva?
Senza dimenticare poi che per Jeremy Bentham (1748-1832) e gli utilitaristi siamo per natura materialisti e, in quanto tali, cerchiamo di ottimizzare il piacere e di mitigare il dolore.
Si è poi proseguito nell’esporci che alla fine dell’Ottocento, col nascente interesse per il funzionamento della mente umana nacquero le discipline psicologiche ma senza minimamente portare novità sull’essenza della natura umana. Anzi,confermando l’idea, secondo la teoria di Charles Darwin (1809-1882), che il principale impegno di ogni uomo o donna fossero la sopravvivenza fisica e la riproduzione.
Lo stesso Sigmund Freud (1856-1939), per quanto sia stato considerato rivoluzionario, non fece altro che recepire sia le argomentazioni materialiste dell’Illuminismo settecentesco che la versione secolarizzata di quanto sostenuto dalla Chiesa medievale, della una natura depravata della specie umana. La pesante eredità che Freud ci ha lasciato, secondo Chiara Pavone, sarebbe in sostanza una trasposizione erotica dell’interesse individuale materialista.
La stessa civiltà più in generale, si ridurrebbe, così, a sancire il compromesso, subito dall’uomo, tra un pò di felicità per un pò di sicurezza.
Ad ogni scolaretto bisognerebbe anche dire che…
Ci fu però chi rifiutò la raffigurazione freudiana dello spirito umano. Negli anni Venti e Trenta lo psicologo Ian Dishart Suttie (1898-1935), ad esempio, fu uno di questi.
Egli inizia notando che stranamente assente dall’analisi di Freud è qualsiasi approfondita considerazione sull’amore materno: una forza potente e inoppugnabile che si riscontra fra ogni animale che alleva la propria prole.
Ma a quasi un quarto di secolo di distanza andrebbe segnalato che Ashley Montagu (1905-1999) avrebbe scritto che le convinzioni di Freud erano vittima di un approccio maschilista tale da relegare ai margini il ruolo della donna.
Sennonchè gli effetti della Prima e della Seconda rivoluzione industriale avrebbero dissolto i fondamenti del patriarcato, liberando le donne da millenni di subordinazione. Decisivi in tal senso risultarono la stampa , con in cima il ruolo giocato dal romanzo sentimentale -come specchio in cui osservare se stesse e le proprie relazioni-; il telefono come strumento capace di superare le pareti del focolare domestico e l’alfabetizzazione di massa destinato a mettere la donna su un piano di parità con l’uomo dal punto di vista della. L’energia del vapore e l’elettricità avrebbero permesso infine alle donne di accedere in fabbrica a mansioni prima dipendenti dalla forza fisica. commerciali.
Tale fenomeno trova il proprio complemento anche in campo scientifico, laddove il primo psicologo di grande levatura a contestare le tesi di Freud fu una donna: Melanie Klein (1882-1960). Con la sua teoria della «relazione oggettuale» destinata a ridare un ruolo decisivo alla figura materna contestando il presupposto di Freud per cui il bambino nasce per espropriare e distruggere, spinto dalla libido. Saranno però William Ronald Dodds Fairbairn (1889-1964) , Heinz Kohut (1913-1981), Donald Woods Winnicott (1896-1971) e il succitato Ian Dishart Suttie ad andare oltre sostenendo che è la socialità la pulsione primaria e che libido, aggressione e distruzione costituiscono una risposta compensatoria alla sua frustrazione.
Per questi psicologi, in sostanza, le relazioni con gli oggetti non dipendono dalla convenienza e dalla necessità di soddisfare la libido, ma dal bisogno di rapporti umani, di amore, di affetto e di compagnia.
Fairbairn rovescia la tesi di Freud, affermando che la struttura dell’Io comincia a svilupparsi alla nascita e che gli impulsi sono gli strumenti attraverso i quali l’Io cerca la relazione con gli altri. In altre parole, il principio di realtà esiste fin dal parto. Ogni bambino cerca l’altro e costruisce ponti di socializzazione, se non veri e propri legami, fin dalla nascita. Fairbairn puntualizza che «in fondo, le “pulsioni” devono essere considerate semplicemente come componenti delle forme di attività che costituiscono la vita delle strutture dell’Io», e che questa attività è diretta alla creazione di relazioni. Il principio di realtà, nell’idea di Fairbairn, è primario. Il bambino è continuamente impegnato a creare connessioni con gli altri, al fine di consolidare le relazioni.
Questo è il vero significato del principio di realtà. Nella misura in cui l’obiettivo primario della socialità è frustrato e all’Io non è consentito di maturare adeguatamente, il principio di piacere subentra come mero sostituto.
Altri si unirono a Fairbairn nella critica alle tesi di Freud e nel delineare una controteoria della natura umana centrata sull’importanza della relazione sociale per lo sviluppo della psiche e del sé.
E’il caso di Heinz Kohut secondo cui la pulsione distruttiva non è intrinseca all’uomo ma, al contrario, è un’espressione del fallimento nella costruzione di relazioni affidabili.
Dando rilievo, però, all’empatia nello sviluppo di un sé maturo con conseguenze imprevedibili sulla formazione dell’Io in sua assenza.
Kohut giunge a distinguere, aspetto di cui troviamo un riflesso pure nella teoria nonviolenta, l’assertività propria del bambino, dall’aggressività, dalla rabbia e dalla distruttività. Mentre la prima è strumentale alla formazione dell’Io e allo sviluppo di un sé maturo, le altre sarebbero la reazione alla mancata realizzazione della relazione sé-oggetto a causa di un deficit empatico di uno o di entrambi i genitori. Peraltro è sostanzialmente indifferente chi sia il fornitore delle prime efficaci cure parentali.
Da parte sua, Donald W. Winnicott, di formazione pediatra , mette in discussione la concezione stessa del bambino come un piccolo individuo autoreferenziato che vede il mondo come un luogo in cui soddisfare i propri appetiti. Per la semplice ragione che ad un primo stadio di sviluppo non si è ancora costituito un Sé individuale. Perché se è vero che il bambino si forma nell’utero, l’individuo si forma nella relazione. Questa precede l’individuo, non viceversa. In sostanza, non sarebbero gli individui a creare la società, ma la società a creare gli individui.
Se però Fairbairn, Kohut e Winnicott, ciascuno hanno minato scalfito i presupposti della psicoanalisi freudiana, Ian Dishart Suttie ha proposto una spiegazione della natura umana speculare a quella di Freud. Individuando nel bisogno innato di socialità non solo uno strumento primario del neonato per assicurarsi la sopravvivenza ma la sua centralità nella natura umana. Al punto che sarebbe l’intero ambiente sociale ad occupare la posizione originariamente occupata dalla madre.
Il ruolo del gioco.
Sarebbe in particolare il gioco la più importante attività sociale, quella attraverso cui creiamo comunione, generiamo fiducia reciproca, esercitiamo l’immaginazione e la creatività individuali. Il gioco è l’ambito nel quale superiamo il senso di solitudine esistenziale e ritroviamo il sentimento di comunione che abbiamo scoperto con il nostro compagno di giochi primordiale: nostra madre.
Suttie ribadisce la propria convinzione che la compagnia e il gioco siano essenziali nell’evoluzione personale dell’essere umano sottolineando che il periodo fra la prima infanzia e l’età adulta [è] dominato da un bisogno di socialità quasi insaziabile, che ricorre all’energia plastica degli interessi umani per soddisfare il desiderio di gioco.
Il più noto psichiatra John Bowlby (1907-1990), fortemente influenzato da Konrad Lorenz (1903-1989), che nel 1935 aveva pubblicato un importante lavoro sull’imprinting degli uccelli, sosteneva che la prima relazione del bambino con la madre ne determina l’intera vita emotiva e mentale e che la pulsione primaria del bambino fosse la ricerca della relazione con gli altri.
Oggi le teorie di Bowlby sembrano ovvie, ma non dobbiamo trascurare che solo negli anni Sessanta negli Stati Uniti e Gran Bretagna e alla fine degli anni settanta in Europa i pediatri hanno cominciato ad ispirare ad esse i consigli per i genitori sul rapporto con i neonati.
Tutto ciò non senza opposizioni ferree. Specie da parte dei comportamentisti che, in linea con quanto sostenuto dallo psicologo John Broadus Watson (1878-1958) negli anni Venti, ritenevano che se i neonati vengono viziati da un eccesso di affetto e di «coccole», diventano meno adattabili nel futuro.
Ma come si cresce un bambino empatico?
Ma come si può rafforzare l’empatia nel bambino? Non certo insegnandogli o imponendogli di essere empatico, ma essendo in empatia con il bambino. L’idea di relazione che il bambino si forma non può che fondarsi sulle relazioni delle quali ha avuto esperienza.
I teorici delle relazioni oggettuali hanno messo in una nuova luce la natura umana, e ciò che hanno scoperto indica che siamo una specie animale affettuosa e altamente socievole, che desidera la compagnia, odia l’isolamento ed è biologicamente predisposta a manifestare empatia verso gli altri esseri.
Del resto non siamo gli unici, fra gli animali sociali, ad avere la capacità di empatizzare con i nostri simili e con le altre creature
I neuroni specchio: l’istinto dell’empatia
Nel 1996 il gruppo di ricerca parmense di Giacomo Rizzolatti, nel 2015 insignito della laurea honoris causa dall’Università degli Studi di Sassari, pubblicò i risultati delle proprie ricerche, provocando un vero e proprio terremoto nel mondo accademico. Come noto i ricercatori battezzarono la scoperta «neuroni specchio». Essi consentono all’uomo e ad altri animali di «mettersi nei panni degli altri» e sperimentare pensieri e comportamenti altrui «come se» fossero propri. Le pubblicazioni scientifiche a carattere divulgativo hanno iniziato a riferirsi ai neuroni specchio come ai «neuroni dell’empatia». Secondo Rizzolatti, ciò che è più sorprendente è che «i neuroni specchio ci permettono di entrare nella mente degli altri non per un ragionamento concettuale, ma attraverso una simulazione diretta: attraverso la sensazione, non il pensiero».
La scoperta dei neuroni specchio ha costretto biologi, filosofi, linguisti, psicologi e molti altri a rimettere in discussione la dicotomia cartesiana mente-corpo, che isolava la ragione dalle sensazioni corporee, dai sentimenti, dalle emozioni, rendendola una forza autonoma, incorporea.
È noto da tempo che gli uomini e altri mammiferi sono «animali sociali». La scoperta dei neuroni specchio, però, apre la porta all’esplorazione dei meccanismi biologici che rendono possibile la socialità.
Uno dei massimi ricercatori nel campo dei neuroni specchio, Marco Iacoboni, neuroscienziato della University of California di Los Angeles, arriva persino a sostenere che noi siamo programmati per l’empatia: fa parte della nostra natura e ci rende esseri sociali. Del resto l’ultimo Darwin arriva a parlare di istinto sociale. E che non appena sarà onorata e praticata da alcuni di noi, questa virtù si diffonderà attraverso l’istruzione e l’esempio ai giovani e, alla fine, sarà incorporata nella pubblica opinione.
La crescente quantità di studi empirici sul ruolo che i neuroni specchio giocano nello sviluppo empatico è impressionante e sta contribuendo a riscrivere la storia dello sviluppo umano.
Analogamente, i ricercatori hanno scoperto che nei bambini autistici i circuiti dei neuroni specchio non funzionano, o funzionano solo parzialmente. E che i circuiti biologici si attivano con l’esercizio sociale: in altre parole, l’ambiente famigliare e sociale dei neonati è essenziale per l’attivazione dei circuiti dei neuroni specchio e per stabilire percorsi empatici nel cervello. Tali scoperte stanno riaprendo l’annosa questione del rapporto fra biologia e cultura e innescando un acceso dibattito nel campo delle scienze naturali e sociali.
La scoperta dei neuroni specchio, oltre ad abbattere il caposaldo del dualismo cartesiano, ci permette di ipotizzare che la frattura stessa fra biologia e cultura sia ugualmente erronea.
Gioco e sviluppo
Molti zoologi odierni ritengono che il «gioco» svolga un ruolo decisivo nello sviluppo dell’empatia e nell’instaurazione di comportamenti pro sociali, proprio come accade fra gli uomini. Il gioco è il mezzo per creare attaccamento, attenzione, fiducia, affetto e legami sociali durante la crescita e per mantenere la socialità nell’età adulta.
Ecco infatti le caratteristiche essenziali del gioco:
È un’esperienza fisica: in genere non pensiamo al gioco come a qualcosa che si fa autonomamente, nella propria testa (quella sarebbe solo una fantasia); è un’attività che ci impegna con gli altri. Raramente è strumentale: il gioco è un fine in sé e per sé.
L’ambiente di gioco è la palestra in cui apprendiamo a essere in empatìa con i nostri simili, in cui esercitiamo la nostra immaginazione mettendoci nei panni e nel ruolo di altri personaggi, cercando di sentire, pensare e comportarci come pensiamo farebbero loro. Quando i bambini giocano, e sono cani e cavalli, medici e pazienti, padri e madri, sorelle maggiori e fratelli minori, maestri di scuola e presidenti degli Stati Uniti, stanno facendo pratica di estensione empatica.
Obiettivamente è difficile immaginare come si possa sviluppare l’empatia in assenza di gioco. Lo storico Johan Huizinga (1875-1945) giunge addirittura a definire l’uomo come Homo ludens, l’uomo che gioca. Egli ipotizza che tutte le culture abbiano radici nel gioco: «Con quei giochi la collettività esprime la sua interpretazione della vita e del mondo».
Lev Semënovič Vygotskij (1896-194), il grande psicologo dei primi anni del Novecento, ci ricorda che «dal punto di vista dello sviluppo, creare una situazione immaginaria può essere considerato un mezzo per sviluppare il pensiero astratto». Vygotskij, giustamente, considera il gioco il livello più alto di sviluppo prescolare.
Ciò che rende il gioco uno strumento così potente di socializzazione è il fatto che si tratta del mezzo attraverso cui si scatena l’immaginazione
Il processo di immaginazione ci permette di legare esperienze corporee, emozioni e pensieri astratti in un unico insieme: la mente empatica. In questo senso, l’immaginazione umana è tanto emotiva quanto cognitiva: simultaneamente esprimiamo emozioni e creiamo pensieri astratti.
Il gioco come libertà
Libertà e gioco, dunque, hanno basi comuni. Il gioco puro è sempre una manifestazione di volontà: nessuno può essere costretto a giocare. Chi gioca si dona liberamente «per amore del gioco», il cui obiettivo è la gioia e la riaffermazione dell’istinto vitale. È attraverso l’esperienza del gioco nella sfera culturale che si apprende a partecipare apertamente all’interazione con altri esseri umani. Diventiamo veramente umani solo rivelandoci all’altro. L’essere umano non può essere realmente libero se non è in grado di lasciarsi pienamente coinvolgere in un gioco. Fu il filosofo Jean-Paul Sartre (1905-1980) ad affermare che, quando l’uomo si apprende libero e desidera usare la propria libertà, la sua attività è il gioco. Ci si sente mai tanto liberi come quando si gioca?
Come si sviluppa l’empatia nel bambino: i genitori dovrebbero sapere che…
In che modo i bambini apprendono a trasformare la propria innata spinta biologica all’espressione empatica in una coscienza empatica matura? Per Martin Hoffman in Empatia e sviluppo morale: implicazioni per la cura e la giustizia, Cambridge University Press 2000, dipende dal modo in cui i genitori li sottopongono alla disciplina delle regole.
La chiave per trasformare gli impulsi empatici innati in risposte empatiche mature è, infatti, nelle modalità con cui si educa alle regole.
La disciplina induttiva
Ovviamente, infliggere punizioni corporali a un bambino a fronte di trasgressioni sociali ha un’elevata probabilità di sortire l’effetto opposto e rendere il giovane meno empatico nel futuro.
Invece, il miglior modo di portare un bambino a esprimere tutto il proprio potenziale empatico è l’induzione, in cui i genitori mettono in evidenza il punto di vista dell’altro, sottolineano la sua sofferenza e chiariscono che la causa di essa è stata la condotta del bambino. Se tale intervento viene compiuto con cura, sensibilità ed equità, e se il bambino si rende genuinamente conto di aver causato disagio all’altro, può portare al senso di colpa, al rimorso e a un sincero impegno a fare ammenda. Per esempio, come riferisce Chiara Pavone, se un bambino sottrae un giocattolo a un altro, il genitore potrebbe sedersi accanto a lui e domandargli come si sentirebbe se qualcuno gli facesse la stessa cosa. Dopodiché potrebbe domandargli di immaginare come si sente, adesso, l’altro bambino.
Così, l’induzione, come altre forme di insegnamento della disciplina, porta il bambino a rendersi consapevole della disapprovazione dei genitori e gli offre anche delle occasioni di apprendimento sociale. Sottolineando il disagio della vittima e chiedendo al bambino come si sentirebbe lui nelle medesime circostanze, il genitore fa sì che si inneschino i meccanismi di stimolo dell’empatia. Per esempio, il genitore potrebbe chiedere al figlio di raggiungere l’altro bambino e guardarlo negli occhi: lo sguardo triste della vittima e le lacrime che rigano il suo viso possono provocare una reazione di imitazione automatica nel trasgressore, che potrebbe a sua volta scoppiare in lacrime. Analogamente, chiedendo al bambino di immaginare come si sente l’altro, si può innescare un’associazione mediata. L’insorgere del disagio empatico si trasforma in senso di colpa e in desiderio di risarcire la vittima.
La disciplina induttiva è una sorta di sceneggiatura, afferma Hoffman, che segue un copione prevedibile: prima «la trasgressione del bambino, seguita dall’induzione del genitore, seguita dal sentimento di sofferenza empatica del bambino e dal suo senso di colpa», in un processo che termina con il suggerimento da parte del genitore di una soluzione riparatoria – chiedere scusa alla vittima, o abbracciarla, o darle un bacio – e il conseguente insorgere nel bambino di un senso di sollievo e di diminuzione della colpa.
Il genitore sufficientemente capace – come direbbe Winnicott – nei momenti in cui esercita la propria funzione disciplinante applica sul bambino solo le pressioni strettamente necessarie, affinché sia disposto ad ascoltare ciò che ha da dirgli sul disagio provocato a qualcun altro. Se si approccia il comportamento del bambino in maniera non giudicante, ma attenta e partecipe, è molto probabile che si inneschi il disagio empatico e il senso di colpa, con il conseguente desiderio di riparazione nei confronti della vittima.
Colpa senza vergogna
Ciò che l’azione disciplinante induttiva insegna realmente al bambino è la sostanza della moralità umana: responsabilità per le proprie azioni, compassione per gli altri, disponibilità ad accorrere in loro aiuto e confortarli, un adeguato senso di equità e giustizia. La maturazione dell’empatia e lo sviluppo del senso morale sono la stessa cosa.
La colpa, però, non deve essere confusa con la vergogna. Spesso i due termini sono usati come sinonimi, ma in realtà sono assai diversi. Mentre la colpa può innescare il disagio empatico e il desiderio di farsi avanti e fare ammenda nei confronti della persona che è stata ferita, la vergogna ci umilia e ci fa sentire privi di valore e di umanità.
Essere additati alla vergogna significa essere rifiutati. La vergogna è un modo per isolare la persona dalla collettività, facendola diventare estranea, una non persona. La vergogna ha l’effetto di spegnere l’impulso empatico innato.
Paradossalmente, per quanto una cultura della vergogna pretenda di aderire ai più elevati standard di perfezione morale, in realtà produce una cultura di odio contro se stessi e invidia, gelosia e rabbia verso gli altri.
L’empatia verso le specie viventi
Infine, la forma più matura di risposta empatica è la capacità di sentire la sofferenza di un intero gruppo di uomini, o perfino di altre specie, come se fosse la propria. Spesso, questo accade se si empatizza con una sofferenza personale, ma questa sofferenza è contemporaneamente simbolo della condizione di un intero gruppo (per esempio, le donne stuprate, certe minoranze religiose o gli omosessuali, tutte categorie che soffrono a causa del rifiuto da parte della cultura dominante).
L’universalizzazione dell’empatia, fino a includere gruppi di persone o categorie di esseri, tende al concetto di coscienza universale.
Cambiamenti fondamentali nelle modalità di accudimento genitoriale e nei comportamenti di attaccamento, il prolungamento dell’adolescenza, fenomeno che per tendenza dominante viene invece considerato di per sè negativo, la maggiore esposizione alla varietà di persone, comunità e culture, una maggiore connettività globale, una crescente interdipendenza economica e stili di vita più cosmopoliti contribuiscono all’universalizzazione della coscienza empatica.
Conclusioni.
Se tutto ciò è presente nei libri, perché a partire dalla scuola si insegna ancora una visione dell’uomo che risale a quanto di lui si pensava nel medioevo?
Ecco perché neanche la cultura, e non per essere complottisti, ce la conta ancora giusta.
Pier Gavino Sechi.