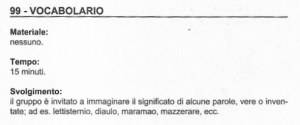Premessa
Ci soffermiamo ancora sul gioco Vocabolario che da il titolo al presente brano e che abbiamo presentato nello scritto della settimana scorsa Quale innovazione? L’Innovanza frutto dell’eguaglianza. Andando con la memoria all’uso che durante i training abbiamo fatto di questo interessante esercizio, salta agli occhi un aspetto particolare. Non ha fatto da apripista per altri giochi neppure in forma di semplici varianti. Invece, un filone interessante, che avrebbe potuto germinare e magari dare l’occasione per aumentare il nostro patrimonio ludico, è quello di esercizi con cui creare nuovi termini. Un po’ come abbiamo provato a fare nel brano precedente. In cui abbiamo proposto il neologismo di Innovanza per mettere l’accento su una particolare forma positiva di innovazione. Quella che si ispira all’eguaglianza e non alla creazione di discriminazioni. Una innovazione inclusiva, dunque, e non escludente.
Tentiamo qui di ampliare il vocabolario con nuovi termini per definire quella complessa realtà costituita dal lavoro.
L’Innovanza: la mediazione tra e innovazione e diritto al lavoro
Oggi vorremmo proseguire il ragionamento, cercando di collegare l’innovazione, a questo punto al rango di termine neutro, con un altro principio fondamentale. Quello del lavoro.
La cornice di riferimento è la medesima già vista per l’innovanza. L’innovazione deve conciliarsi con l’esigenza che non produca processi distruttivi di posti di lavoro. E ciò può essere un corollario dell’innovanza stessa. C’è infatti una sfasatura temporale tra l’avvento delle innovazioni e la possibilità di impiegare in altri settori i lavoratori nel frattempo formati per le mansioni ormai superate. Senza trascurare il numero di professioni che non potranno essere riconvertite. In nome del progresso non si fa mai una valutazione d’ impatto per mitigare i costi sociali.
Una valutazione d’impatto
Sino a quando sarà evidente che il lavoro sarà disponibile solo per un numero esiguo di persone. Il che porrà tre generi di problema: lo squilibrio tra capacità produttive e possibilità di consumo; l’aumento della pressione fiscale per far fronte ai nuovi bisogni dell’era post-lavoro; l’ aumento della tassazione sulla quantità residua di lavoro, divenuta bene scarso. Non si può escludere che in tale scenario si possa accentuare il ruolo di sindacati e associazioni imprenditoriali nel cercare di fare da frizione tra le opposte esigenze. E di ragionare sulla valutazione di impatto per registrare una vera e propria esternalità negativa. Proprio in quanto non si tratta di una merce qualsiasi ma di un prodotto che non ha solo la funzione e assume valore solo se scambiato. Ma già mentre si svolge.
La fine del lavoro per l’ accesso ai beni
Il tema del lavoro, dunque, è caldissimo. Con una temperatura che con le tappe forzate dell’innovazione sta diventando esplosiva. Ma in verità è in crescita da secoli (chi non ricorda il luddismo? per la cui rilettura vai suLuddismo ) sino a che negli anni settanta, senza reticenze, si parlava della possibilità di non considerare più necessario (cioè possibile) il requisito del lavoro per l’accesso ai beni e ai servizi essenziali.
In realtà, come al solito, il gioco che dobbiamo essere abili a condurre torna ad essere quello del saper vedere meglio e distinguere.
Lavoro ed ecologia sociale
Intanto, il lavoro in tutte le sue forme ha sempre racchiuso in sé una componente trasformativa, se è vero quello che secondo Gregory Bateson ogni scolaretto dovrebbe sapere che “dal nulla non nasce nulla”. Che fa il paio con ciò che ogni terrestre dovrebbe sapere, ossia che nulla sta immobile ma si trasforma continuamente,producendo entropia o, in altre parole, disordine. A pensarci è questo il nocciolo duro dell’intera Agenda 2030. In futuro occorrerà porre l’attenzione sull’ entropia sociale nell’ambito del tema dell’ecologia sociale.
Ecco allora che il lavoro, nel senso di trasformazione, è un processo che prescinde dall’intervento umano. Esso può solo accelerarlo e orientarlo verso certe forme e non altre.
Da questo punto di vista paradossalmente si potrebbe dire che il vero lavoro è terminato con i sette giorni della creazione divina dal nulla di tutte le cose. E dalla settimana successiva è iniziata la storia del lavoro come semplice trasformazione.
Epoca che sembra a sua volta destinata a consumarsi una volta che l’artificiale avrà sostituito il naturale per riprendere la messa in guardia di Hans Jonas.
Allora ciò che sembrava promettere di positivo la formula della fine del lavoro deve essere inteso in questo senso.
Mentre rimane in piedi, ed anzi acquista maggiore importanza, l’altra valenza del lavoro. Quella degli effetti che produce in chi lo compie. Effetti che da sempre sono stati materiali ma anche spirituali.
I primi consistono nella remunerazione, i secondi nell’affermazione della propria efficacia.
Il ritorno dell’io
A lungo ha resistito il mito che i due aspetti fossero un binomio inscindibile sino a quando la psicologia del lavoro, riassumibile, per i trainers cagliaritani dagli anni 80, con l’insegnamento del Ritorno dell’io nell’organizzazione di Enzo Spaltro, ha finito per sfatarlo. Oggi si riconosce che il primo è condizione necessaria ma non sufficiente della seconda. E che questo richiede una dimensione relazionale e sociale che da senso al primo. Ne è una dimostrazione il fenomeno organizzativo del promoveat ut amoveat. Cioè una promozione, persino non solo retributiva ma funzionale, non scalfisce il messaggio disconfermante che un’impresa può indirizzare al lavoratore di cui non può liberarsi.
Dal lavoro all’occupazione
Allora il lavoro oggi deve assumere il significato, più appropriato, di occupazione per diventare qualcosa di cui le persone devono nutrire letteralmente preoccupazione. Nel senso di effetto del tenere a qualcosa di cui ci si prende cura. In questo modo il termine occupazione può prestarsi a ricomprendere tutte le varie forme di attività con le quali l’uomo progetta il futuro. Da quelle trasformative forti, come quelle industriali, a quelle più leggere e immateriali sino all’ otium latino.
L’ Innovanza potrebbe realizzare questa seconda forma di occupazione per tutti se oltreche‘ volerlo fermamente, vincessimo quella che Enzo Spaltro chiama la cultura della scarsità a fronte della cultura dell’ abbondanza. Oggi siamo fermi ancora ad un vocabolario che non va oltre il detto che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Dovremmo osare di più e allenarci a vedere la vita stessa come un gioco a somma diversa da zero.
Forse sta qui una possibile chiave di lettura dell’avvertita insufficienza delle misure contro le povertà. Esse liberano dalla necessità di soddisfare i bisogni dei primi gradini della scala di Maslow, ma ancora nulla possono sulla condizione che i beneficiari soddisfino i bisogni più elevati. Basta notare i reati oggi commessi. I loro moventi diventano illeggibili senza comprendere che i bisogni sottostanti sono quelli più sofisticati come il riconoscimento da parte degli altri. O la reputazione. Cui si tende comunque. Anche se negativa, in mancanza della capacità di puntare a quella positiva.
Creare capacità e non esclusione
Realisticamente, allora siamo al punto di poter dire che mentre il denaro arriva a soddisfare i bisogni difensivi, quelli primari e posti sui primi gradini della scala di Maslow, per soddisfare quelli più alti sono richieste capacità, per usare un termine caro a Martha C. Nussbaum, Creare capacità, Bologna, 2012.
Ma dove le si può imparare, dove le si esercita e come? In un contesto di apprendimento significativo (la scuola?) per rispondere alla prima parte della domanda. Con una occupazione relazionale, per rispondere alla seconda parte.
Ossia un’attività che occupa e per cui ci si preoccupa e che si sostanzi in un gioco cooperativo. Per cui la ricompensa è il riconoscimento dell’utilità da parte degli altri. Un gioco che abbia tutti quegli aspetti relazionali ben messi in luce da un testo di Eric Berne, A che gioco giochiamo, Roma, 2000, che ogni terrestre dovrebbe conoscere.
Pier Gavino Sechi.