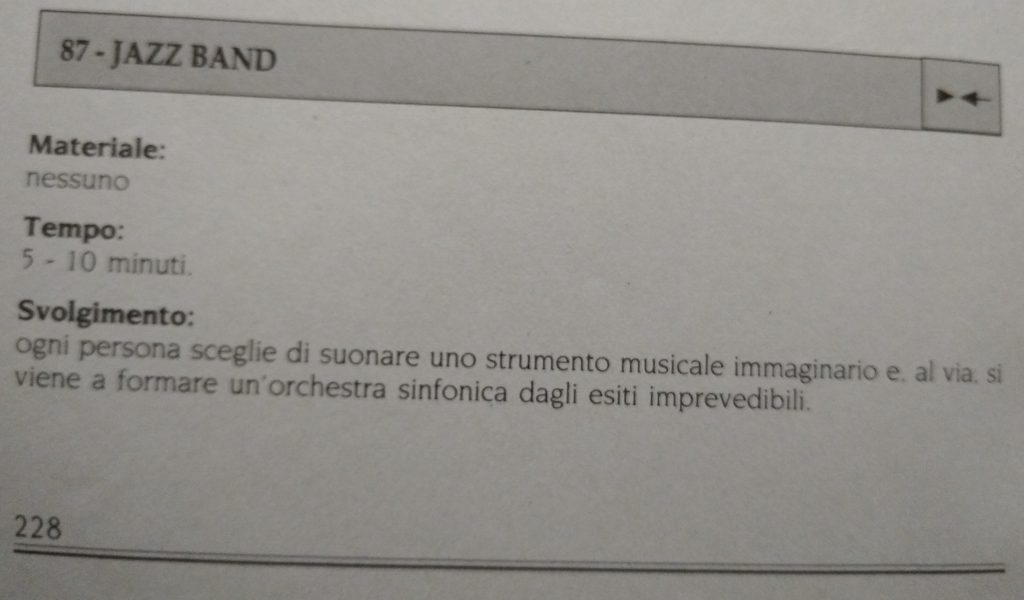Premessa.
Come ideale ponte tra i due brani precedenti, proponiamo questo dal titolo Jazz band. Dedicato all’omonimo gioco descritto qui sotto. Uno dei più interessanti giochi basati sul suono. Ossia su un elemento non secondario su cui si basa la comunicazione umana. In grado non solo di esprimere e suscitare stati d’animo e sentimenti ma, come dimostra l’esercizio, di strutturare campi significativi di relazione e di azione.
A noi sembra interessante metterlo in continuità con le riflessioni che stiamo sviluppando, sia per evidenziare che l’armonia tra suoni diversi costituisce uno dei più classici esempi di gioco a somma diversa da zero. Sia per attirare l’attenzione su come il campo musicale porti un forte attacco al concetto di gerarchia.
L’ armonia non sempre fa rima con gerarchia
In un’orchestra ha poco senso , infatti, parlare di strumenti più o meno importanti. Anzi qualsiasi sia il loro numero, quello che pure in teoria conterebbe di meno, in quanto con un peso poco rilevante nella partitura, ha più probabilità di incidere sulla qualità complessiva dell’esecuzione. Pensiamo all’unico colpo di gong dato fuori tempo nel finale. Sarebbe tutto da rifare se il concerto non fosse in diretta.
In Jazz band, in particolare, il suono ha la funzione di dare letteralmente il là al concatenarsi di altri suoni senza che nessuno di essi vada oltre il rapporto di complementarità. Come se non ci siano i margini per quel processo che Gregory Bateson chiamava schismogenesi.
Può essere questa una delle ragioni della funzione creativa e liberatoria della musica? Della sua capacità onirica di trasportarci in una dimensione in cui sono sospese gli ordinari criteri con cui ordiniamo la realtà?
Cambi di registro
Non sembra differente la situazione dell’assertivo alle prese con l’obiettivo di far cambiare musica al contesto in cui si trova.
Egli all’inizio si sentirà un clamans in deserto, come chi prende l’iniziativa emettendo il primo suono in Jazz band, e rimarrà solo nel ripeterlo sino a che altri non decideranno di “seguirlo”. Un verbo, questo, assai ambiguo in quanto esprime simultaneamente due tipi di relazione. Quella causale e quella temporale.
L’iniziatore di un vero processo di cambiamento cercherà di mettere in luce il secondo significato. In modo tale che chi ha da esprimere qualcosa ma non volesse dare l’idea di farlo per effetto di qualcun altro, possa farlo potendo dire di averlo voluto fare dopo aver visto “la proposta” e averla trovata interessante. Ebbene, pur di ottenere comunque il cambiamento, l’assertivo è disposto a tenere conto anche di tali “bizzarrie”. Non importa se poi non gliene verrà dato merito. Del resto i profeti, col chiarimento etimologico del quale (colui che parla avanti) Alberto Melucci apre il suo L’invenzione del presente, spesso sono anche quelli destinati a non godere dei risultati annunciati.
Ristrutturazione non fa rima con manipolazione
Immaginiamo che un tale modo di leggere le relazioni umane, possa suscitare la critica di opportunismo e manipolazioni. Quando in realtà va considerato che sarebbe vero il contrario.
La manipolazione, difatti, non consiste certo nel comprendere le ragioni dell’altro, ma nel cercare di indurre gli altri a fare qualcosa che non vorrebbero.
In verità noi stiamo parlando della sottile arte della ristrutturazione. Ossia di quella capacità di aprire e far aprire gli occhi su aspetti della realtà mai prima considerati. In modo tale che accada come il cieco che benchè acquisisca la vista grazie ad altri, possa esclamare “Ci vedo” piuttosto che “Mi avete ridato la vista”. Questa sorta di protagonismo, di attribuzione alla proprie capacità il raggiungimento di un risultato è fondamentale per radicare il cambiamento. In quanto solo se è frutto di una nostra conquista siamo in grado di difenderlo con forza dagli ostacoli successivi. E ciò può accadere se il cambiamento è frutto di una scelta libera.
In questo senso va compreso il tentativo di riabilitazione che Vittorio Hosle in Filosofia della crisi ecologica fa dell’egoismo. Piuttosto che condannarlo e reprimerlo, col rischio che si rinforzi e diventi una forza distruttiva, consiglia di consideralo una forza vitale. Rispetto al quale operare una chiara indicazione di fini costruttivi.
L’abbiamo già visto parlando del prevaricatore. Egli ritiene che sia possibile ottenere risultati per se positivi a discapito degli altri. La sua capacità di vincere andrebbe perciò orientata verso obiettivi relazionali in cui la vittoria è senza vittime. Non è perciò la sua determinazione verso l’obiettivo a dover essere messa in discussione quanto la sua direzione verso un obiettivo inclusivo dell’altro. Altro che non è più destinato ad essere vittima ma altro vincitore col quale rinforzare la vittoria.
La suggestione di Vittorio Hosle, perciò, non solo appare interessante, ma persino obbligatoria e necessaria difronte alle grandi sfide della complessità e della globalità. Che richiedono non repressione delle forze vitali, ma loro potenziamento verso obiettivi ricalibrati secondo una visione complessa. Capace di sostituire all’io il noi, al bene individuale il bene pubblico.
Gli equivoci del bene pubblico
Ma perchè una tale ricostruzione sta ancora stentando ad essere condivisa? Sarebbe improprio e persino incoerente attribuirne la causa al dilagante egoismo. Quando invece sarebbe necessario osservare che è stato di ostacolo la concezione di bene pubblico come antitetico rispetto al bene individuale. Come se il primo potesse realizzarsi a discapito del questo. Una sorta di espropriazione.
Non è il primo caso in cui la visione antinomica della realtà produce effetti negativi. Ma in questo caso i danni sono assai gravi in quanto la visione minacciosa del bene comune ha accentuato l’attaccamento al bene individuale. Forte di tutta una serie di caratteristiche, quali la concretezza, la misurabilità, la controllabilità, etc., tali da renderla preferibile ad un concetto, a questo punto, assai vago impersonato dal bene comune.
Se, invece, usciamo dalla visione manichea e riflettiamo che il naturale sviluppo del bene individuale sia quello comune, e che questo ha bisogno del primo, per un suo più completo conseguimento, perde importanza il bene individuale in sè. Non foss’altro perchè se non cè anche il bene comune, quello individuale, diventando scarso, rischia di dover essere difeso più che goduto.
Stili di conduzione
A pensarci bene, dunque, all’assertivo interessa il cambiamento di per sè e non per sè. Questa è al limite una mera conseguenza.
E qual’è la modalità che più che essere manipolatoria possa fungere da comportamento in grado di dare il la, senza traccia di direttività ma al contempo dotata di indicatività?
Esaminando la letteratura sulla leadership possiamo giungere ad una possibile risposta. Per cui quella che presenta la maggiore efficacia dal punto di vista del nostro discorso è senz’altro quella per cui il leader è al contempo un leader di se stesso. In grado cioè di osservare per primo egli stesso le regole che indica agli altri. Ed anzi in caso di scarsità di risorse disposto a rinunciare a quelle personali pur di garantirle ai suoi collaboratori.
Si tratta in sostanza di quel tipo di leader che fonda sulla testimonianza la funzione di indicare le regole per se vincolanti. Come presupposto per poterne attenderne il rispetto anche da parte degli altri.
Questa figura poco sembra conciliarsi, come anticipato, con le esigenze di una struttura gerarchico-militare, se pensiamo che in caso di pericolo è il capo ad essere per primo tratto in salvo. Per consentirgli di impartire gli ordini anche nelle successive fasi dello scontro col nemico.
Ma sappiamo come lontano dal dolore fisico e chiuso nella stanza dei bottoni, per un capo siffatto si creano tutte le condizioni perchè la guerra si trasformi in un tragico videogioco.